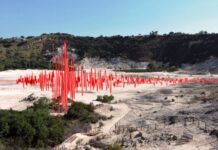Tre giorni da leoni: vigilia, Natale e Santo Stefano. Colesterolo alle stelle e trigliceridi in libera uscita. Ma cinquant’anni fa, o giù di li, queste cose nessuno le sapeva. Anche perché le analisi del sangue, spesso, all’ammalato venivano fatte solo quando era rimasto ben poco da fare. E comunque, la devozione, come si diceva allora, voleva che almeno in quel periodo la miseria e i problemi di mala salute fossero banditi dalle case. Chi poteva si attrezzava al meglio. E chi non poteva, spesso faceva debiti e accattava ‘ncrerenza, comprava a credito, pur di farsi una solenne mangiata. Una pietanza che non doveva mancare su nessuna tavola, la sera della Vigilia, era la classica linguina con alici, pignuoli (pinoli) e noci scamazzate (schiacciate). Alla salsina così preparata si potevano unire (ma erano in pochi a chiederlo) qualche chicco di uva passa (‘e ppassare). Il tutto, veniva soffritto, solo per pochi secondi, con aglio e olio. Ovviamente, il piatto andava ulteriormente insaporito aggiungendo peperoncino, ‘o pupanio, a volontà. La qual cosa significava pure che la bocca e l’esofago si incendiavano e c’era bisogno di alcuni bicchieri di buon vino del Vesuvio per spegnere il fuoco. Che, nel corso dei giorni successivi, per colpa di quei pupanielli spesso si riaccendeva e iniziava ad ardere in altre «località» del corpo. E la ci voleva ben altra cosa per lo spegnimento. Non c’era antipasto: e chi lo conosceva. Quella sciccheria, all’epoca la si poteva gustare solamente quando si aveva la fortuna di andare a un matrimonio in un ristorante. Allora sentivi dire, per meglio far capire che s’era trattato di una cosa in grande, ce steva pure ll’antipasto, penzate quanto ‘a famiglia ‘e essa s’ha fatto ‘nteresse: c’era anche l’antipasto, pensate quanto i famigliari di lei (a cui toccava pagare il pranzo di nozze) hanno speso. Immediatamente dopo, se la famiglia ne aveva la possibili-tà, seguiva anche lo spaghetto con le vongole. Che invece erano solo lupini (arselle). Seguivano alcuni pezzi di baccalà ‘nfarenato (infarinato) e fritto cu ‘e cchiòchiare (sorta di peperone tondo, messo sotto aceto), ‘na mez’anguilla arrestuta (una mezza anguilla arrostita) e duje cucchiare ‘e ‘ammarielle sfritte cu ‘o fforte (due cucchiai di gamberetti d’acqua dolce soffritti con peperoncino). Alla fine del pranzo e prima della seccumma (seccume, frutta secca): noci, nucelle (nocciole), cacace (arachidi) e ammennole (mandorle) e d’’e ccose doce (cose dolci): roccocò, susamielli, raffaiuoli e mustacciuoli, era obbligatorio nu piattiello de ‘nzalata ‘e rinforzo (un piattino colmo d’insalata di rinforzo), un trionfo di verdura fatto di scarole ricce mescolate ad alici sa-late, sottaceti, carciofini, melanzane e quant’altro la dispensa era in grado di offrire.
Tre giorni da leoni: vigilia, Natale e Santo Stefano. Colesterolo alle stelle e trigliceridi in libera uscita. Ma cinquant’anni fa, o giù di li, queste cose nessuno le sapeva. Anche perché le analisi del sangue, spesso, all’ammalato venivano fatte solo quando era rimasto ben poco da fare. E comunque, la devozione, come si diceva allora, voleva che almeno in quel periodo la miseria e i problemi di mala salute fossero banditi dalle case. Chi poteva si attrezzava al meglio. E chi non poteva, spesso faceva debiti e accattava ‘ncrerenza, comprava a credito, pur di farsi una solenne mangiata. Una pietanza che non doveva mancare su nessuna tavola, la sera della Vigilia, era la classica linguina con alici, pignuoli (pinoli) e noci scamazzate (schiacciate). Alla salsina così preparata si potevano unire (ma erano in pochi a chiederlo) qualche chicco di uva passa (‘e ppassare). Il tutto, veniva soffritto, solo per pochi secondi, con aglio e olio. Ovviamente, il piatto andava ulteriormente insaporito aggiungendo peperoncino, ‘o pupanio, a volontà. La qual cosa significava pure che la bocca e l’esofago si incendiavano e c’era bisogno di alcuni bicchieri di buon vino del Vesuvio per spegnere il fuoco. Che, nel corso dei giorni successivi, per colpa di quei pupanielli spesso si riaccendeva e iniziava ad ardere in altre «località» del corpo. E la ci voleva ben altra cosa per lo spegnimento. Non c’era antipasto: e chi lo conosceva. Quella sciccheria, all’epoca la si poteva gustare solamente quando si aveva la fortuna di andare a un matrimonio in un ristorante. Allora sentivi dire, per meglio far capire che s’era trattato di una cosa in grande, ce steva pure ll’antipasto, penzate quanto ‘a famiglia ‘e essa s’ha fatto ‘nteresse: c’era anche l’antipasto, pensate quanto i famigliari di lei (a cui toccava pagare il pranzo di nozze) hanno speso. Immediatamente dopo, se la famiglia ne aveva la possibili-tà, seguiva anche lo spaghetto con le vongole. Che invece erano solo lupini (arselle). Seguivano alcuni pezzi di baccalà ‘nfarenato (infarinato) e fritto cu ‘e cchiòchiare (sorta di peperone tondo, messo sotto aceto), ‘na mez’anguilla arrestuta (una mezza anguilla arrostita) e duje cucchiare ‘e ‘ammarielle sfritte cu ‘o fforte (due cucchiai di gamberetti d’acqua dolce soffritti con peperoncino). Alla fine del pranzo e prima della seccumma (seccume, frutta secca): noci, nucelle (nocciole), cacace (arachidi) e ammennole (mandorle) e d’’e ccose doce (cose dolci): roccocò, susamielli, raffaiuoli e mustacciuoli, era obbligatorio nu piattiello de ‘nzalata ‘e rinforzo (un piattino colmo d’insalata di rinforzo), un trionfo di verdura fatto di scarole ricce mescolate ad alici sa-late, sottaceti, carciofini, melanzane e quant’altro la dispensa era in grado di offrire.
Assieme alle cose doce, era obbligatorio mangiare anche ‘o suricillo (topolino) una specialità della zona di Boscotrecase, ap-prontata con fichi secchi imbottiti con noci e nocelle (qualcuno metteva anche scorzette d’arancia e mandarino candito); il tut-to veniva fatto insaporire nel vino cotto, avvolto in foglie di fico, e messo a cuocere in un forno dal calore dolcissimo, perché il dolce non diventasse secco e duro. Un bicchierino di ammiccato e la cena della Vigilia di Natale finiva con la classica tumbulella, tombola, tirata dalla più anziana della famiglia che sapeva a memoria i significati dei numeri. Spesso, per quel gioco si univano tre, quattro, o più famiglie e allora la serata, tra un ambo, un terno e una tombola chiena, passava senza che te ne accorgevi, e s’arrivava a mezzanotte allorché si tirava la stella e si cantava Quanno nascette Ninno, la pastorale di Sant’Alfonso de’ Liguori. Qualche minuto prima dell’ora X si iniziava la sparatoria con le botte.
Termine generico, quest’ultimo, forse troppo. Perché tra le “botte” erano comprese : tricche tracche, (tracchi) botte a muro (botti che scoppiavano sbattendo contro un ostacolo), trunielle (petardi), botte cu ‘o sisco (botti col fischio) e cepolle (grossi petardi a miccia lunga). Insomma ce n’era per tutti i gusti e di tutte le dimensioni. Ai più piccoli toccava solamente qualche bastoncino per le stelline i cosiddetti fit-fit. Il giorno di Natale, il pranzo non cambiava di molto. Ovviamente, bisognava osservare strettamente il dettato religioso che imponeva di andare a messa. Le donne di casa, lo facevano di mattina presto. Tra le sette e le nove. Poi era di nuovo un mettersi in marcia per approntare il pranzo della festa. Che non si discostava molto da quello della Vigilia. Gli unici piatti che cambiavano, in alcuni casi, erano i primi che prevedevano ziti o zitoni spezzati con le mani e conditi con ragù, e il secondo che prevedeva il crapetto (capretto) con contorno di patate fritte e piselli e qualche pezzo di stocco condito con limone, oltre il baccalà, la frittura di anguille, secce (seppie) e calamari e ammarielle ‘e sciummo, gamberetti di fiume. Di sera?
E che vuoi mangiare, visto e considerato che spesso si arrivava alle otto senza nemmeno alzarsi da tavola. E allora? Tutto come la sera precedente: mandarini, roccocò, bicchierini di ammiccato e di nuovo tombola. A Santo Stefano le cose cambia-vano. Bisognava stare leggeri, dopo aver mangiato tutto qual ben di Dio. E dunque era tempo di menesta maretata, minestra maritata. Solo che la maritavano con più mariti e allora le cose si ricomplicavano. Ci mettevano tracchiulelle ‘e puorco (costine di maiale) na meza recchia (mezzo orecchio) e nu poco ‘e pere (un poco di piede) sempre dello stesso; na meza pullanca (una mezza gallina giovane); quacche piezzo ‘e cuperte ‘e custate (qualche pezzo di coperta di costato: carne per bollito). Non dimenticando l’uosso masto (il femore) del manzo o vacca che fosse. E poi, c’era la verdura. Le specie? Quante più ve n’erano meglio veniva il matrimonio.
Mentre il colesterolo suonava e i trigliceridi ballavano.
Mica per niente Natale veniva una sola volta all’anno.
Carlo Avvisati